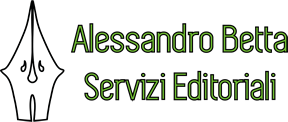Giappone mon amour
Sull’Impero dei segni di Roland Barthes
[…] Posso anche, senza pretendere assolutamente di rappresentare o analizzare la minima realtà (sono questi i fondamenti principali del discorso occidentale), prelevare in qualche parte del mondo (laggiù) un certo numero di “tratti” (termine grafico e linguistico) e con questi tratti formare deliberatamente un sistema. Ed è appunto questo sistema che io chiamerò il Giappone.[1]
La dimensione della cultura è piuttosto di natura abissale che estensiva. Certo, le distanze hanno il loro peso e rendono ragione delle molte differenze, più o meno spiccate, tra i diversi sistemi culturali, e talvolta di curiose tangenze (per lo più di cagione storica) e di eventuali, fortuite convergenze evolutive.
Ma è nella discesa verticale, con l’inclinazione dello speleologo allo scandaglio delle profondità, che si può restituire l’intima fisionomia di una cultura, le sue geometrie interne, i ponti che ne reggono la struttura, i collegamenti fra i volumi. Raggiungere così stanze nascoste ma vitali, seguendo vene precise che conducono ai più imi recessi.

Esempio di kintsugi
La vena dei “tratti” che Barthes elige a portante nel suo Impero dei segni ricompone ventisei frammenti – di cui pochi prenderemo in esame – che isolano altrettante peculiarità della cultura giapponese, per renderne infine e «deliberatamente» un sistema. Come nella suggestiva tecnica del kintsugi,[2] tale sistema mostra a poco a poco la sua forma in una molteplicità di segni impreziosita dall’aureo legante dell’essenzialità, della rimozione, dell’esenzione, ossia il vuoto, l’immediato, in antitesi al pieno, al sovrabbondante, all’elaborato (o sofisticato?) proprio dei modi espressivi occidentali.
La lingua
Di contro al mito, rinverdito dal giapponismo pop dell’ultimo decennio, l’ineffabile non è prerogativa della cultura del Sol Levante, tant’è che se ne parla eccome. È forse, piuttosto, un’approssimazione, un’iperbole idealizzante o una percezione distorta dall’aura di esotismo che circonda questo Paese ancora lontano, malgrado tutto. “Rarefazione” rende già molto meglio; e poi “nitore”, “purezza”, “pulizia”, “delicatezza”, “impalpabilità”… Ma quante parole. E solo per accostarsi appena al concetto che intuiamo ma che il nostro grimaldello linguistico sembra inadatto a forzare. L’errore sta nel pertinace tentativo di spiegare il Giappone creando intorno alle sue tipiche manifestazioni impalcature di senso che convertano codici altrimenti alieni in un sistema interpretativo a noi familiare. Ma questo non è che un buon modo per snaturare l’oggetto di studio.
Barthes mette a fuoco lo scarto culturale tra l’Occidente convesso e il concavo Oriente giapponese, dove la semantica non prolifera ma si ritira, si sottrae, abbandona ogni sovrastruttura in favore di un’essenzialità espressiva che, di necessità, ne plasma l’estetica.
[…] conoscere, riflesse positivamente in una lingua nuova, le impossibilità della nostra; apprendere la sistematicità di quello che non si può concepire; disfare il nostro “reale” sotto l’effetto di altre suddivisioni, di altre sintassi; scoprire nuove posizioni del soggetto nell’enunciazione, dislocare la sua topologia: in una parola, scendere nell’intraducibile, provarne la scossa senza mai attutirla, sino a che in noi tutto l’Occidente si scuota e vacillino le leggi della lingua paterna.
[…]
Così in giapponese, la proliferazione dei suffissi funzionali e la complessità delle enclitiche implicano il fatto che il soggetto avanzi nell’enunciazione grazie a precauzioni, riprese, ritardi e insistenze, il cui volume finale […] fa appunto del soggetto un grande involucro vuoto della parola, e non quel nucleo pieno che si presume diriga le nostre frasi, dall’esterno e dall’alto; di modo che ciò che appariva come eccesso di soggettività (il giapponese, suol dirsi, enuncia delle impressioni, non delle constatazioni) è invece piuttosto un modo di diluizione, di emorragia del soggetto in un linguaggio frazionato, parcellizzato, diffratto sino al vuoto.[3]
Il soggetto si eclissa o tuttalpiù non interviene che con la sola azione: fa ma non interpreta, dice ma non sentenzia, insomma si guarda bene dall’ammantare di significati le manifestazioni della realtà che lo circonda e che – questo sì, ineludibile – è già stata franta una volta e n’è stato isolato un singolo frammento, l’enunciato.
Maschere
Vi è poi nelle lingua giapponese un tratto affascinante: accanto alla forma corrente, fiorisce un sistema di stili e riferimenti onorifici che adattano la comunicazione al contesto. Così, a seconda delle situazioni, si adotterà uno stile familiare, uno piano, uno cortese o uno formale; uno stile maschile o uno femminile; si sceglierà, nella moltitudine e con la dovuta cura, un affisso onorifico adatto all’interlocutore… Uffici che, di nuovo, celano il soggetto dietro il paramento della consuetudine.
Altro aspetto culturale dei più noti è la marcata cortesia del popolo giapponese. Un fraintendimento tutto occidentale, s’intende: l’europeo è spesso portato a considerare intrinseco un aspetto della cultura nipponica che poco ha a che fare con l’interiorità degli individui e molto con la convenzione sociale.
Celebre è l’usanza orientale (non solo giapponese) dell’inchino; meno nota è invece la convenzione, appunto, che rifrange tale gestualità in una rosa di variabili, ciascuna dotata di un preciso valore comunicativo. Innanzitutto è bene distinguere due classi principali di inchini: ritsurei (立礼), gli inchini in piedi; e zarei (座礼) gli inchini in ginocchio.

Esempio di saikeirei.
Tra i primi esiste un grado di inclinazione regolato dai rapporti sociali (di gerarchia, di classe) tra gli interlocutori: compiremo l’eshaku (会釈), ossia un inchino accennato, come saluto quotidiano ad amici e parigrado, inclinando la schiena di 15 gradi. Di fronte a un superiore, al lavoro, compiremo il keirei (敬礼) inclinando la schiena fra i 30 e i 45 gradi; infine, mostreremo la nostra massima deferenza con il saikeirei (最敬礼), un inchino compreso fra i 45 e i 90 gradi, e di maggior durata.
Tra gli zarei, accanto alle forme elencate sopra ma eseguite in posizione seiza (正座, la seduta tradizionale), vi è il dogeza (土下座), un gesto profondamente umiliante che consiste nel prostrarsi sfiorando il terreno con la fronte in segno di supplica o richiesta di perdono per qualcosa di molto grave.
Il fraintendimento cui si accennava più indietro sta qui: nel pensare che un simile apparato culturale influenzi in qualche modo l’interiorità del popolo che lo impiega, e che dunque chi pratica l’inchino sia per natura più accondiscendente col prossimo.
Ebbene, tale pensiero sarebbe plausibile solo a patto di una consistente semplicità di vedute e dell’ignoranza di due concetti fondamentali nel sistema relazionale giapponese: l’hon’ne (本音) e il tatemae (建前). Entrambi hanno a che fare con il nascondimento, la finzione, il mascherare il soggetto perché si adatti a consuetudini sociali superiori all’individuo. Se il tatemae è la facciata, e rappresenta la forma esteriore che si deve mostrare, sempre intonata al contesto, l’hon’ne è il pensiero genuino, il vero sentimento del soggetto, che può concordare con il tatemae così come può discostarsene fino a esserne opposto, ma sempre celato.
Il cibo
Questa disposizione al ritrarsi, al non contaminare i fenomeni, non è ristretta al solo ambito della lingua e delle relazioni.
In una rosa di capitoli iniziali, Barthes si concentra sulla cucina giapponese: orizzontale, non gerarchica, essa apparecchia sulla tavola pietanze modulari suddivise in piccole porzioni ordinate. Sovente le materie prime non vengono alterate, se non nella forma attraverso raffinate tecniche di taglio, così che, nel caso più noto del pesce, siano ben riconoscibili anche proposte come sashimi, nigiri o maki. Il taglio, per l’appunto, è forse l’operazione più invasiva; i brodi sono spesso limpidi; i sapori più soffusi dei nostri dolce, salato, amaro, aspro eccetera, così tondi, definiti e contrastivi. Il Giappone non ricerca l’amalgama trasformativa che in Occidente trasfigura le pietanze, le ricopre di salse, persino le camuffa giocosamente fino al parossismo (letterario) della cena Trimalchionis.[4]
Dunque, da un lato il significante (l’alimento) si mantiene integro senza subire che poche, necessarie ingerenze da parte di un soggetto (il cuoco); dall’altro la sintassi dell’alimentazione, in quanto modulare e, come si è detto, orizzontale, è disponibile a piacimento.
Una maniera di intendere che torna, nuovamente, alla scrittura, nota Barthes, specie in quella poetica (haiku), dove la modularità della versificazione e la brevità del componimento non lasciano spazio ad altra significazione se non quella della lettera, laddove in Occidente una tale maniera si segnala come innovativa, di rottura: si pensi al frammentismo ungarettiano del Porto sepolto (1916) che, pur con cautela e senza conferme dirette da parte dell’autore, si ipotizza influenzato dalla allora recente penetrazione della poesia giapponese in Europa.[5]
Le cose

Composizione ikebana. Ukiyo-e di Harunobu Suzuki, 1765.
Frammento, parcellizzazione, si è detto. Barthes dice «minuzia»: per tornare al cibo, le porzioni
sono piccole per essere mangiate, ma esse sono anche commestibili per compiere la loro essenza, che è la minuzia.[6]
E una volta varcata la soglia della cultura giapponese, tanto ci appare per ogni elemento del cosmo:
Se i mazzi di fiori, gli oggetti, gli alberi, i volti i giardini e i testi, se le cose e i modi giapponesi ci appaiono minuti (mentre la nostra mitologia esalta la grandezza, la vastità, la larghezza, l’apertura) non è tanto a causa della loro misura, ma è perché ogni oggetto, ogni gesto, anche il più libero, il più mobile, sembra incorniciato.[7]
Questo è importante: l’impressione che ogni fenomeno della cultura tradizionale giapponese sia preciso al punto da sembrare, per quanto minimo, codificato, quasi rituale, è da ricercare nella totale adesione al contesto di tali fenomeni: una tale grado di armonia tra estetica, gusto e funzionalità rende un profondo senso di coerenza, la cornice cui Barthes fa riferimento.
La poesia
Tutto questo può lasciar intendere che l’arte del Sol Levante consista nel poco e dunque nel facile. Specie in poesia:
Lo haiku ha una proprietà un poco fantasmagorica: che ci si immagina sempre di poterne comporre da sé con facilità.[8]
Della storia e delle peculiarità della poesia haiku ho già detto diffusamente nel quartetto Haiku – Anatomia di un genere, a cui rimando, perciò non mi dilungherò in spiegazioni. Dirò soltanto lo stretto necessario, e cioè che la brevità e lo schema di tre versi organizzati in 5-7-5 sillabe possono trarre in inganno, come ben nota Barthes. Non solo: l’immediatezza espressiva, cioè la proprietà dello haiku di non voler esprimere null’altro che la propria lettera, anzi, dice Barthes, il suo non voler dire proprio nulla, rischia di ingannare il lettore occidentale, così assuefatto alla stratificazione dei significati, alla loro reciproca compenetrazione, al simbolo e alla sua decrittazione, insomma: allo sforzo interpretativo.
Pur essendo del tutto intelliggibile, lo haiku non vuole dire nulla, ed è per questa doppia condizione ch’esso sembra offerto alle interpretazioni in un modo particolarmente disponibile, servizievole, come un ospite cortese che vi permette d’installarvi comodamente in casa sua, con le vostre manie, i vostri valori, i vostri simboli […].[9]
Questa apparente facilità di decifrazione illude l’occidentale di poter comprendere un senso che non c’è («lo haiku non vuole dire nulla») e allo stesso tempo di essere in grado di replicare una simile prova d’arte con una manciata di parole, magari fuori metro, che evochino un’immagine ordinaria, didascalia di un sentimento o di una suggestione. Non pago, e preda di un horror vacui aere perennius, accanto a questo l’Occidente seguita a percepire l’urgenza di una spiegazione, una parafrasi che sciorini quel senso che non può non esserci.
Noi abbiamo due modi per evitare al discorso l’infamia del non-senso e sottomettiamo sistematicamente l’enunciato […] all’una o all’altra di queste significanze (ovvero la fabbricazione attiva di segni): il simbolo e il ragionamento, la metafora e il sillogismo.
[…]
Nemmeno un tratto che, nel commento occidentale, non venga investito di una valenza simbolica. O meglio, si vuole a tutti i costi intravvedere nella terzina dello haiku […] il disegno di un sillogismo in tre tempi […].[10]
Perché tutto ciò?
Perché…
… se si rinunciasse alla metafora o al sillogismo il commento diventerebbe impossibile: parlare dello haiku sarebbe semplicemente ed esattamente ripeterlo.[11]
Come questo, di Matsuo Bashō:
日わつれなくも
秋の風
hi wa tsurenakumo
aki no kaze
insiste il sole:
vento d’autunno.
*
Note
[1] Roland Barthes, L’impero dei segni, Torino, Einaudi, 1984, p. 5.
[2] Kintsugi (金継ぎ): da kin (金) “oro”, e tsugi (継ぎ) “riparazione”; tecnica di riparazione di oggetti in ceramica che consiste nel ricomporne i frantumi con lacca dorata.
[3] Roland Barthes, cit., pp. 9-12.
[4] Era un grande vassoio rotondo su sul quale si vedevano incisi i dodici segni dello zodiaco, e ciascun segno il cuoco aveva posto una burlesca vivanda… Sopra l’Ariete, dei ceci cornuti; sopra il Toro, una bistecca di manzo; sopra i Gemelli, dei testicoli e del rognone; sopra il Cancro, una corona; sopra il Leone, dei fichi africani; sopra la Vergine, una vulva di scrofa; sopra la Bilancia, due piatti contenenti l’uno una torta e l’altro una focaccia; sopra lo Scorpione, un pesce di mare; sopra il Sagittario, un gallo selvatico; sopra il Capricorno una aragosta; sopra l’Acquario, un’oca; sopra i Pesci, due triglie. Nel centro poi, c’era una zolla erbosa con un favo di miele.
[…]
… accorsero quattro servi a suon di musica e tolsero la parte superiore del vassoio mostrandoci il ripieno di cacciagione e di petti di scrofa, che stava sotto. Nel mezzo troneggiava una lepre con le ali, perché somigliasse a Pegaso. Agli angoli del piatto c’erano poi quattro satiri, dalle cui cornamuse gocciava una salsa sopra i pesci che vi nuotavano come in un lago.
(Gaio Petronio Arbitro, Satyricon, XXXV-XXXVI)
[5] La critica di inizio Novecento non è molto bendisposta nei confronti dell’esordio ungarettiano, al contrario della corrente ermetica, che lo accoglie con favore. Sulle postulate tangenze con la cultura giapponese, si veda l’articolo: Le radici del poeta. Parte II: Ungaretti, haiku, giapponismo di Nicolò Bindi.
[6] Roland Barthes, cit., p. 21.
[7] Ivi, p. 51.
[8] Ivi, p. 80.
[9] Ibid.
[10] Ivi, pp. 81-83,
[11] Ivi, pp. 83-84.