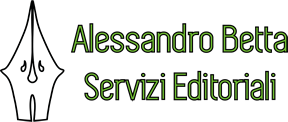Nel regno dei demoni
Marco Aurelio a sé stesso
Il regno dei demoni è null’altro che un auspicio, un ideale, forse un’utopia e dunque un’iperbole dal carattere asintotico, che tuttavia bene orienterebbe la bussola dell’umanità.
Se in molti avvertono nel nostro tempo una deriva incauta, smodata, di cui avremo un giorno di che rammaricarci tutti, non è certo un caso. Come specie, abbiamo intrapreso una via che ci riserverà una doppia insidia: l’inasprimento di annosi problemi che, per incapacità o interesse, non abbiamo ancora risolto[1]; la regressione a stadi primitivi della nostra storia, in cui, su ogni scala, dominerà il conflitto come mezzo privilegiato per la risoluzione delle contese o come perverso terreno di collaudo delle idee: se ti sconfiggo, se ti umilio pubblicamente, allora la mia idea è la migliore.
Non è questo il mondo cui, oggi, aspira una persona equilibrata e a cui stanno a cuore i valori della democrazia, della condivisione, del confronto dialettico, insomma la più alta declinazione dell’illuminismo che si sarebbe potuta praticare in questo primo quarto del nostro secolo.
Di gran lunga preferibile sarebbe diventare cittadini di un fantastico regno dei demoni, meta cui ciascun essere dotato di ragione dovrebbe guardare, dal momento che questo reame anticipa e trascende ogni interesse e ogni ambizione.
Non si tratta certo di un progetto politico, quanto più di un proposito esistenziale, un gesto intellettuale e personale a cui qualcuno si sente naturalmente incline; qualcun altro ne avverte la necessità ma non saprebbe metterlo in forma; qualcun altro ancora potrebbe esserne attratto all’improvviso, dopo lungo tempo speso a guardare altrove, per serendipità.
A sé stesso
Non di certo la soluzione, ma un valido indirizzo di ricerca per tentare di sanare le storture del nostro presente, è nella filosofia. In particolare nella tradizione stoica che attraverso il preminente filtro di Epitteto, e in talune consonanze col pensiero senecano, approda alla raccolta di riflessioni di Marco Aurelio, anepìgrafa e oggi nota col titolo di Pensieri, o Colloqui con sé stesso o, più semplicemente, A sé stesso. Un’opera in dodici libri che racchiude appunti di lettura, brevi esortazioni, massime morali, indicazioni di buon comportamento, meditazioni sul ruolo dell’essere umano e del suo rapporto con le persone, con la virtù, con la morte, con l’universo… Tutto ciò destinato a una fruizione privata, redatto nella forma dell’annotazione autoreferenziale assimilabile alla diaristica, ma in realtà distante da essa in quanto priva di intento memoriale. È invece un’opera di sistematica introspezione volta alla ricerca e all’emendazione delle proprie fallacie; opera che Marco Aurelio stende in maniera non organica nell’ultimo decennio della sua vita, tra il 168 e il 179[2].
Ho letto questo libro sull’onda della necessità di mettere ordine ai miei, di pensieri, in un momento di convulsione e disorientamento. Ho colto l’occasione per soggiornare in un’oasi meditativa tutt’altro che confortevole – e così deve essere: solo da un libro inutile il lettore si congeda quale era prima – pervasa da una profonda volontà di comprensione dell’animo umano, dell’agire morale e del significato della felicità, ovvero della sua sostanza e della sua locazione. Sono entrato in un regno dei demoni fittizio, poiché esso vive soltanto sulla pagina, ma che, se ben frequentato, potrà forse permettere a ciascuno, dentro di sé, di edificare il proprio.
Le chiavi del regno
Vive con gli dèi chi continuamente mostra loro la propria anima soddisfatta di ciò che gli viene assegnato in sorte, e in atto di compiere quanto vuole il demone che Zeus, quale frammento di sé, ha dato a ciascuno perché lo guidi e lo diriga. Questo demone è l’intelletto e la ragione di ciascuno. (V, 27)[3]
È sufficiente questo breve passo a compendiare una buona parte del pensiero di Marco Aurelio. Innanzitutto l’affermazione di un principio superiore e regolatore – qui, naturalmente, il divino – dal quale discendono i demoni che presiedono il regno ideale postulato nelle righe precedenti. E quei demoni sono “l’intelletto e la ragione di ciascuno”, cioè la facoltà di raziocinio e, fondamentale, il suo impiego. Ma non solo: essi derivano dal divino, ne sono diretta emanazione e l’uomo ne partecipa compiutamente. In altri termini, più vicini al razionalismo del nostro tempo, è l’universo che ci contiene, nel suo insondabile intreccio di stati e probabilità, ad aver instillato in noi la scintilla della ragione.
Vivere con gli dèi è dunque onorare la propria natura di essere razionali, cioè far uso della propria facoltà per nutrire il proprio demone o “principio dirigente”, e così perseguire il bene e la virtù, quindi la felicità.
[…] mentre gli altri esseri sono stati costituiti per gli esseri razionali ‒ e, del resto, in ogni altra situazione gli esseri inferiori sono costituiti per quelli superiori ‒, gli esseri razionali sono stati costituiti gli uni per gli altri. Quindi il valore eminente nella costituzione dell’uomo è l’inclinazione a vivere in società; al secondo posto viene la facoltà di non cedere alle passioni del corpo; infatti è proprio del movimento della ragione e dell’intelletto circoscrivere se stesso e non risultare mai inferiore al movimento dei sensi e a quello degli impulsi, poiché questi ultimi sono entrambi movimenti animali, mentre il movimento dell’intelletto vuole avere il primato e non essere dominato da quelli. Giustamente, senza dubbio, perché è nella sua natura disporre e servirsi di tutti quelli. La terza caratteristica, nella costituzione dell’essere razionale, è non esser precipitoso nei giudizi e non lasciarsi ingannare. Attenendosi a queste peculiarità, quindi, il principio dirigente percorra la retta via: e avrà ciò che è suo. (VII, 55)
Marco Aurelio scrive anche di “sorte”, che noi intenderemmo quale “destino”, un sentiero già tracciato da altri per noi, che spesso non conosciamo e a cui siamo legati senza appello: una concezione teleologica e superstiziosa che ancora sopravvive in molti.
Che cosa pensa al riguardo Marco Aurelio?
In clausola al libro V torna sul concetto di “sorte” con queste parole:
Un tempo ero, in qualunque situazione fossi colto, un uomo fortunato; ma «fortunato» significa: che ha assegnato a se stesso una buona sorte; e una buona sorte significa: buone inclinazioni dell’anima, buoni impulsi, buone azioni (V, 37).
Per alcuni aspetti, anche in questo passo l’imperatore si accosta a una concezione dell’uomo cara alla nostra contemporaneità, forse perché d’ispirazione e in un certo qual modo mitopoietica: quella del self-made human, la persona che s’è fatta da sé e detta agli altri la propria figura, i propri confini, determina sé stessa sotto ogni luce, ed è al contempo artefice delle proprie fortune e responsabile delle proprie sventure. Una monade, insomma, autarchica e individualista, l’uomo (inesistente) del XXI secolo.
È, questa, una prossimità verosimile con l’idea dell’imperatore?
No. È invece scomposta, frutto piuttosto di un nostro eventuale errore di prospettiva: il considerare l’universale con le categorie del presente, dunque finite e di necessità transitorie. E allora perché l’umano tratteggiato in queste righe non corrisponde all’umano contemporaneo? O, meglio, perché l’umano dei nostri giorni non è il naturale traguardo dell’umano tratteggiato qui?
La sorte è intesa non soltanto come ciò che un’entità superiore ha riservato per noi, ma rappresenta anche il prevedibile sviluppo delle decisioni che prendiamo nel corso della vita. Vita che non è mai del tutto nostra: la è, certamente, nella misura in cui riusciamo a controllarne appieno taluni aspetti, ma non del tutto perché in ogni istante siamo chiamati al confronto coi nostri simili, con le loro aspirazioni, i loro interessi, le loro passioni e idiosincrasie, coi pochi che ascoltano il proprio demone e coi molti che lo tradiscono. E allora accade che talvolta possiamo solo affrontare – quando non subire – le conseguenze di scelte e azioni compiute da altri che sono più potenti di noi o ci hanno anticipato. È sempre la nostra vita che viviamo, modellata però su circostanze al di fuori del nostro controllo.
Il tempo, la morte
Attraverso le categorie generali (l’uomo, gli esseri razionali) e trascendentali (il divino, la sorte), Marco Aurelio allestisce uno scavo introspettivo e intorno all’agire morale di chi massimamente dovrebbe ricercare la virtù, l’imperatore, sia in quanto essere umano, sia in quanto apice del potere costituito.
Oltre all’esercizio del pensiero critico e dell’autoanalisi, è necessario frequentare il principale caposaldo della vita terrena, ovvero il fatto che essa potrebbe spegnersi da un momento all’altro, e che, per quanto durasse mai, una volta conclusa non sarà stata che un istante nella storia del cosmo, tradotto per sempre nell’oblio.
Siamo caduchi. Perfino l’imperatore. Come affrontare dunque l’avvento della morte?
Più di un secolo prima dell’A sé stesso, Seneca scriveva nella prima delle sue Lettere a Lucilio:
Puoi indicarmi qualcuno che dia un giusto valore al suo tempo e alla sua giornata, e che si renda conto com’egli muoia giorno per giorno? In questo c’inganniamo, nel vedere la morte avanti a noi, come un avvenimento futuro, mentre gran parte di essa è già alle nostre spalle. Ogni ora del nostro passato appartiene al dominio della morte. Dunque, caro Lucilio, […] fa’ tesoro di tutto il tempo che hai, sarai meno schiavo del domani. (Ad Luc. I, 1)
O ancora:
Non può godere una vita tranquilla chi pensa troppo a prolungarla e annovera fra i grandi beni il vivere a lungo. Tu, invece, sii sempre pronto a lasciare con animo sereno questa vita, a cui tanti si attaccano come chi è travolto da un vorticoso torrente tenta di aggrapparsi ad ogni arbusto. Gli uomini, in maggioranza, ondeggiano tra il timore della morte e i tormenti della vita; non hanno il coraggio di vivere né sanno morire. (Ad Luc. I, 4)
Colui che dà ascolto al proprio demone sa che la morte è inevitabile, non tanto perché arriverà, ma perché è in atto da che siamo al mondo. È dunque saggio chi si prepara a morire, senza però averne la smania:
L’uomo forte e saggio non deve fuggire dalla vita, ma uscirne. Soprattutto eviti quella passione da cui molti si lasciano prendere: la brama di morire. (Ad Luc. II, 24)
L’uso accorto del tempo come impiego razionale, dunque virtuoso, della vita torna nelle pagine di Marco Aurelio, non privo, anche qui, di un solido indirizzo:
Insomma: la vita è breve; bisogna sfruttare il presente con oculatezza e nel rispetto della giustizia. (IV, 26).
Perseguire il bene e la virtù, il migliorarsi curandosi soltanto del proprio perfezionamento morale – in altre parole, seguire e accudire il proprio demone – è il miglior modo per rendere degna la vita dell’uomo, e dunque anche la sua morte:
Ora, in qualunque momento tu debba uscire dalla vita, se, abbandonato tutto il resto onorerai soltanto il tuo principio dirigente e il divino che è dentro di te, se avrai paura non di dover da ultimo smettere di vivere, ma piuttosto di non aver mai cominciato a vivere secondo natura, sarai un uomo degno del cosmo che ti ha generato e cesserai di essere straniero in patria e di meravigliarti degli avvenimenti quotidiani come di fatti inattesi, e di restare sospeso a questo e a quest’altro. (XII, 1)
Non è una filosofia consolatoria, quella dell’imperatore; è lontana dalla passività epicurea che vede la vita e la morte come stati opposti e reciprocamente escludenti. Diceva Epicuro: perché temere la morte? Quando ci sono io non c’è lei, quando c’è lei non ci sono io. Marco Aurelio, al contrario, e sulla scorta di Epitteto, suggerisce una disposizione attiva verso la morte – che non è, si capisce, libido moriendi[4] ‒ bensì una continua meditazione su di essa:
La morte, l’esilio e tutto ciò che appare terribile ti siano quotidianamente dinanzi agli occhi, più di ogni altra cosa la morte: e non avrai mai alcun pensiero meschino né desidererai mai nulla oltre misura. (Encheiridion, 21)
Oltre a ciò, Marco Aurelio indugia sull’aspetto materialistico dell’evento: dunque morire non è l’opposto del vivere, dacché è bene vivere guardando alla morte, né la soluzione della vita, né tantomeno una facile via di fuga; al contrario è una trasformazione, un passaggio di stato, una tappa naturale della parabola terrena di ciascuno, preferibile, in extrema ratio, a una vita che non permetta di agire secondo il demone. In nessun modo, però, la morte può essere considerata un male, né è da temere. Perché?
Perché per quanto insondabile da vivi, ogni circostanza che facciamo coincidere con essa o non ha connotati morali, o spegne o muta ogni nostra sensibilità, o disgrega i nostri atomi e ci restituisce al tutto da cui ci siamo concretizzati.
La morte, appunto, e la vita, la fama e l’oscurità, il dolore e il piacere, la ricchezza e la povertà, tutte queste cose accadono in egual misura agli uomini buoni e ai cattivi, in quanto non sono moralmente belle né brutte. Non sono, quindi, né beni né mali. (II, 10)
La morte è quiete dall’impressione dei sensi, dagli impulsi che ci muovono come marionette, dalle deviazioni del pensiero, dal servizio che prestiamo alla carne. (VI, 28)
[Sulla morte] O dispersione (nel caso la realtà sia costituita da atomi), o altrimenti (nel caso sia un’unità compatta) estinzione o trasmigrazione. (VII, 32)
Chi teme la morte, teme o l’insensibilità o una diversa sensibilità. Ma se non avrai più sensibilità, non sentirai neppure alcun male; se avrai una sensibilità diversa, sarai un essere diverso e non cesserai di vivere. (VIII, 58)
Che la morte sia un male non è un fatto di per sé, scrive ancora Marco Aurelio, ma un’opinione; ad affliggere l’animo dell’uomo con il timore e il disperato desiderio di procrastinazione non è dunque la morte, ma l’opinione che l’uomo se ne fa, quando considera di essere privato di qualcosa o interrotto nell’atto del vivere. Chi segue il proprio demone sa però che l’opinione non pertiene alla sfera morale ma è solo il filtro con il quale si interpreta il mondo. Tale facoltà di giudizio è una delle poche che sia in nostro pieno possesso, possiamo dunque regolarla, e in questo modo, così come quando qualcuno ci offende è in realtà la nostra opinione intorno alle sue parole a farlo, così la morte quando sopraggiunge non è da ritenersi malvagia, perché è l’uomo con la sua opinione ad attribuirle affezioni morali che non ha:
E tra i principî che più dovranno stare a portata di mano quando ti ripiegherai su di essi, vi siano i due seguenti. Il primo: le cose non toccano l’anima, ma stanno immobili all’esterno, mentre i turbamenti vengono soltanto dall’opinione che si forma all’interno. Il secondo: tutto quanto vedi, tra un istante si trasformerà e non sarà più; e pensa continuamente alla trasformazione di quante cose hai assistito di persona. Il cosmo è mutamento, la vita è opinione. (IV, 4)
Uomini e demoni
Il divino è razionale; il razionale naturale; il cosmo una città abitata da essere per loro natura razionali, e che dunque partecipano del divino, cioè della sostanza del cosmo stesso in una densità concettuale che rende gli esseri razionali uniti in fratellanza dalla razionalità stessa che li accomuna. Nel regno dei demoni l’individualismo non scompare, ma cambia vettore e diventa clitico: ciascuno esiste nella propria individualità, ma con il proprio agire morale, con la consapevolezza che gli esseri razionali esistono gli uni per gli altri, persegue ed esalta l’individualità del prossimo, correggendo ed essendo a un tempo sensibile alle correzioni[5]; sapendo discernere i fatti dalle opinioni e dalle rappresentazioni che di quei fatti ci si crea; agendo in conformità del proprio demone o principio dirigente, l’unica garanzia dell’autenticità dei rapporti coi propri simili, nonché speranza di salvezza di un’umanità – la nostra, oggi – che credendo di scorgere demoni dappertutto, li vuole combattere, ma s’inganna: se il mio nemico fosse un demone, non avrei alcun nemico.
*
Note
[1] Disuguaglianze, discriminazioni, odii, diffusione di un atteggiamento antiscientifico che avversa la lotta alle malattie, all’inquinamento, al riscaldamento globale ecc.
[2] Muore poco prima di compiere 59 anni, nel marzo del 180.
[3] Dove non segnalato diversamente, si intendano le citazioni tratte dall’opera di Marco Aurelio.
[4] Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, I, 24.
[5] Se qualcuno può contestarmi e dimostrare che le mie opinioni o le mie azioni non sono rette, sarò felice di mutare atteggiamento. Perché io cerco la verità, che non ha mai fatto danno a nessuno; mentre infligge un danno a se stesso chi persiste nel proprio inganno e nella propria ignoranza. (VI, 21)